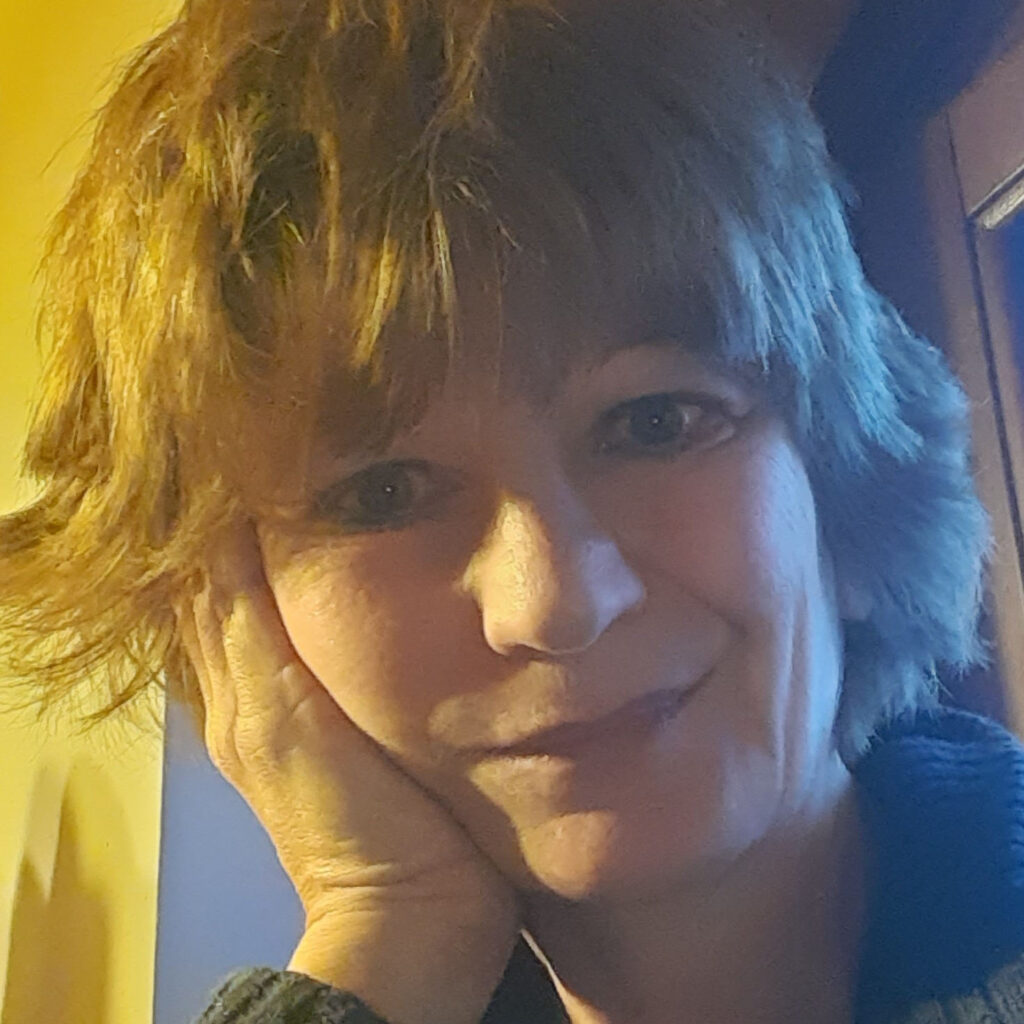LA LEGGE A GUANTANAMO: TORMENTO O BENEDIZIONE?
di Joseph Margulies* Quando penso agli ultimi vent’anni, mi viene in mente la frase dei Grateful Dead: «Lately it occurs to me, what a long strange trip it’s been». I. Come Mai Guantanamo? Immagino che la storia sia familiare, ma molto brevemente, per capire come si sia arrivati a Guantanamo, dobbiamo capire che gli attacchi sono stati interpretati, immediatamente, non come un reato ma come un atto di guerra, e che in questa guerra, l’obiettivo più importante era l’intelligence. Tutto ciò che è avvenuto in risposta all’undici settembre, negli Stati Uniti e in gran parte dell’Occidente, Italia inclusa, si fa risalire a questa comprensione: questa era, ed è, una guerra di intelligence. Siete consapevoli, ad esempio, che tutte le vostre comunicazioni elettroniche possono essere lette dalla NSA. Naturalmente, l’11 settembre è stato un reato. Ma l’obiettivo primario dopo l’11 settembre non è stato quello di risolvere il reato – cioè, arrestare i responsabili e perseguirli – ma prevenire il prossimo attacco. L’amministrazione Bush ha capito, quasi dal primo giorno, che ci sarebbero state operazioni militari in Afghanistan, e che queste operazioni avrebbero portato alla cattura di sospetti prigionieri di Al Qaeda. E poi? Cosa dovrebbe accadere? La risposta era semplice: gli Stati Uniti hanno voluto sviluppare una tipologia di interrogatorio che permettesse di svuotare il contenuto della testa di un prigioniero. Avevano bisogno di un luogo, o diversi luoghi, dove qualsiasi interrogatorio potesse essere condotto in ogni momento, senza alcun controllo giudiziario o vincolo giuridico. Hanno voluto liberarsi dai limiti imposti dal diritto nazionale e internazionale. Secondo l’amministrazione Bush gli interrogatori nel mondo dopo l’11 settembre non dovevano più essere soggetti a nessuna restrizione, a eccezione di quelle che essi stessi si sarebbero volontariamente posti. La maggior parte di questi è stata condotta dai militari americani nelle basi in Afghanistan e Guantanamo. Per raggiungere la massima flessibilità, gli Stati Uniti hanno gettato via la Convenzione di Ginevra. La natura e la brutalità degli interrogatori militari varia moltissimo. Alcune persone vengono interrogate solo brevemente; tuttavia, molte altre centinaia, incluse praticamente tutte le persone trasferite a Guantanamo, sono state soggette a svariati abusi, inclusi la deprivazione del sonno, la manipolazione ambientale, posizioni di stress, umiliazioni fisiche e sessuali e violenze. Abbiamo intentato Rasul v. Bush per rispondere a questo vuoto, questo posto senza i freni della legge. Abbiamo detto in Rasul che non c’è una prigione fuori la legge. Abbiamo voluto inserire la legge in un posto dove, ed a un tempo quando, non c’era ricettività della legge. Che dev’essere un modo per contestare la legittimità legale e fattuale della detenzione in un tribunale, e per mostrare che – in ogni caso particolare – lo Stato ha commesso un errore. Punto. E abbiamo vinto. La Corte Suprema ha detto che i detenuti potrebbero contestare le basi della loro detenzione in tribunale. II. La Legge Come Tormento Anche se abbiamo vinto, la legge ha fallito a Guantanamo, in almeno tre sensi. a. La Legge Come Complice Primo, la legge ha permesso all’amministrazione Bush di creare Guantanamo. Ha permesso la tortura e le prigioni segrete. La legge ha permesso l’intera architettura del regime di detenzione dopo l’undici settembre. In realtà, il regime non sarebbe stato possibile senza la legge. Negli Stati Uniti, veneriamo la legge, e soprattutto la Costituzione. Non è possibile creare un nuovo aspetto della vita americana senza prima dimostrare che è coerente con la Costituzione, e non solo con le parole ma anche con lo spirito della Costituzione. E quindi l’amministrazione ha dovuto stravolgere e contorcere la legge per adattarla a un luogo come Guantanamo ed a una pratica come la tortura. E l’ha fatto. Come ho scritto in un libro, What Changed When Everything Changed, 911 and the Making of National Identity, l’amministrazione ha reimmaginato ciò che la legge consente per preservare il nostro mito di innocenza e purezza. In questo senso, la legge è complice nel tormento. La legge fa parte del nostro incubo dopo 9/11 tanto quanto la tortura che ha permesso. b. La Legge Come Falsa Speranza Anche la legge ha fallito in un senso diverso. In Rasul, non abbiamo vinto un risultato, ma un processo. Quando il tribunale – ogni tribunale – crea un processo, vogliamo credere che sia vero, che sia reale. Vogliamo credere che i risultati del processo saranno divisi tra le parti perché i fatti non favoriranno sempre una parte rispetto all’altra, e quindi le regole che risolvono i casi non favoriranno una parte rispetto all’altra. Che, insomma, ci sia una possibilità di vittoria per tutte le parti. Altrimenti, non è un processo, è una finzione. Quella è la speranza di ogni processo e della legge che l’ha creato. In questo caso – in Rasul – abbiamo ottenuto il diritto di obbligare lo Stato a mostrare le basi legali e fattuali della detenzione di un detenuto. Ma la Corte Suprema ha lasciato i dettagli del processo ai tribunali di grado inferiore, e loro hanno creato un processo in cui lo Stato non può mai perdere e i detenuti non possono mai vincere. Mai. I dettagli non sono importanti ora; ci sono varie presunzioni a favore delle prove dello Stato. Ma il punto è solamente che non è un processo vero. È solo l’aspetto di un processo. È l’opportunità di entrare il tribunale e di iniziare il processo, ma come in un processo alle streghe, tutti conoscono l’esito prima che inizi. c. La Legge Come Mito Anche la legge ha fallito in un terzo senso, un senso più complesso. In un modo collegato al mito della legge. Cioè, purtroppo, esiste un mito negli Stati Uniti che la legge funziona. Che la legge possa limitare il potere. E quando abbiamo vinto Rasul, tutti i giornali e le riviste e la TV hanno detto, “Guarda. Ci piace dire che siamo un paese di leggi e non di uomini, ed è vero. Anche in tempo di guerra, la legge funziona”. In questo senso, la legge rafforza il suo stesso mito. Per me, questo è il
LA LEGGE A GUANTANAMO: TORMENTO O BENEDIZIONE? Leggi tutto »