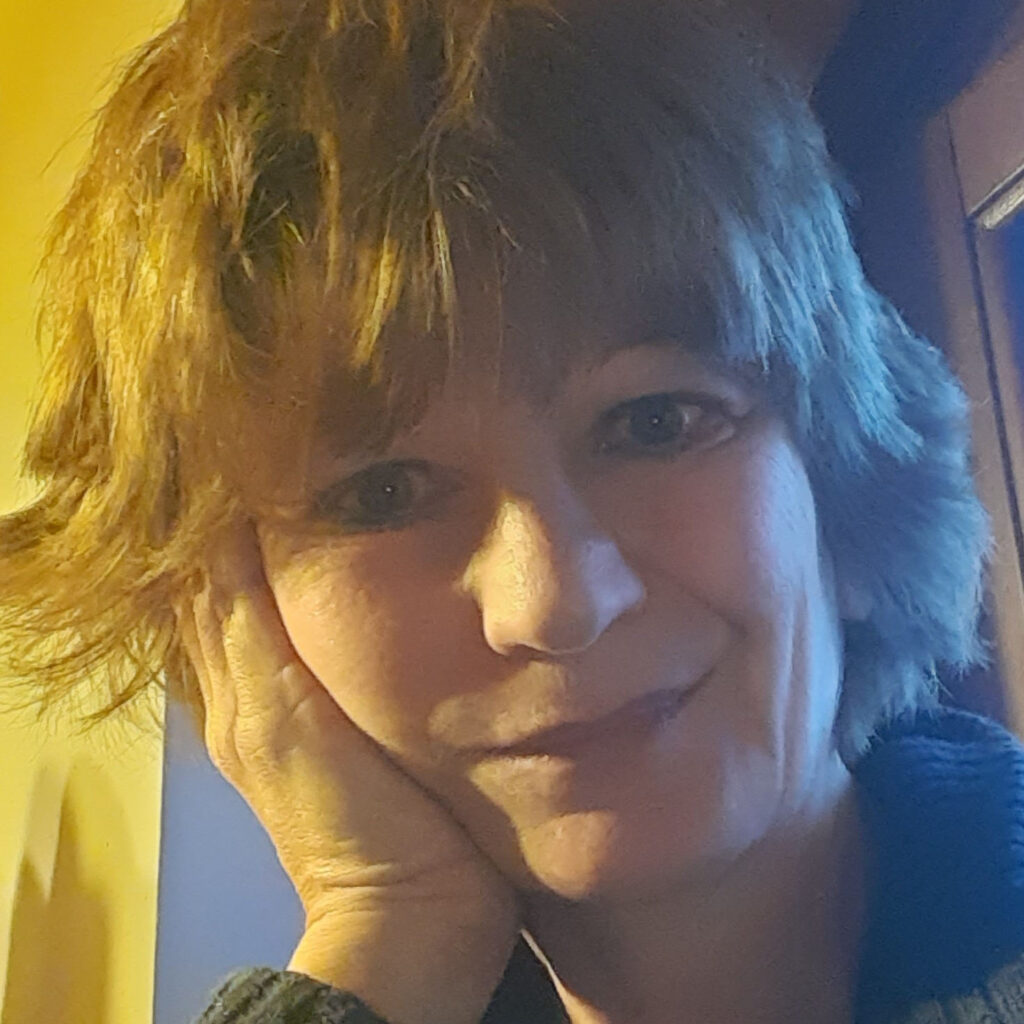L’«UNICA SOLUZIONE POSSIBILE»… È UN’ALTRA. ANCORA CONTRO LA TORTURA
di Marina Lalatta Costerbosa* – Nel suo libro Salvare una vita si può, il filosofo utilitarista Peter Singer scrive: «Prendiamo come esempio l’argomentazione secondo cui la tortura è una pratica da condannare in qualunque caso. Vista la ben documentata propensione di carcerieri e polizia a compiere atti di violenza sui prigionieri e la bassa probabilità di ottenere informazioni utili per mezzo della tortura, sembra verosimile che condannando in toto tale pratica si raggiungano i risultati migliori. Tuttavia, potrei argomentare che se mi trovassi nella assai improbabile condizione in cui solo torturando un terrorista sarebbe possibile evitare l’esplosione di una bomba atomica nel centro di New York, sarebbe mio dovere torturare il terrorista. A volte il mio dovere di individuo non coincide con ciò che prescrive il migliore dei codici morali»1. In una prospettiva simile incontriamo anche la tesi di Michael Walzer sul politico dalle mani sporche. Walzer, nel suo Political Action: The Problem of Dirty Hands, capovolge le note pagine del saggio Sulla pace perpetua nelle quali Kant ci offriva una visione alta della politica e della filosofia proponendone l’intreccio, sì da favorirne il reciproco sostegno. Come aveva osservato in una sua intensa intervista quasi due secoli dopo Hannah Arendt, Kant è stato il filosofo anche autenticamente «politico»2. Per Kant il politico, il «politico morale», nulla ha a che fare con il «moralista politico». Il politico “morale” è colui che tenta di costruire e di sostenere la pubblica libertà di espressione e di pensiero per ogni cittadino, la «libertà della penna», al fine di creare quelle condizioni esterne di possibilità (il diritto) in grado di assicurare il rispetto di ciascuno nella sua autonomia. In una sorta di eroicizzazione del politico disposto a «intrare nel male, necessitato», secondo Walzer, il “politico morale” è, al contrario, disposto a ricorrere, ove indispensabile, anche alla spregiudicatezza, persino alla tortura. Anzi, il politico “morale” lo si riconoscerebbe per lui proprio dalle «mani sporche», che denoterebbero non illegittimità, bensì assenza di ipocrisia e assunzione di responsabilità3. A essere così capovolto è il ragionamento kantiano, e pure l’intendimento di Sartre sotteso al dramma teatrale del 1948 «Le mani sporche», in cui veniva sollevato il problema relativo alla possibilità di esercitare il potere in modo innocente. La risposta di Sartre, con riferimento specifico alla tortura, era stata consegnata alla nota introduttiva di Tortura, la testimonianza tristemente toccante del giornalista Henri Alleg, il racconto delle torture da lui subite in Algeria per mano francese4. È un testo prezioso, in cui Sartre denuncia la sistematica e devastante futilità della tortura, «vana furia, nata dalla paura: si vuole strappare ad una bocca, in mezzo alle grida e ai rigurgiti di sangue, il segreto di tutti. Inutile violenza: che la vittima parli o che muoia sotto le torture, l’innumerevole segreto è altrove, sempre altrove, fuori di portata. Il carnefice si trasforma in Sisifo, se applica la question dovrà sempre ricominciare» 5. Si tortura per torturare, il suo scopo è solo apparentemente legato al contenuto di verità delle informazioni o alla loro utilità. È esibizione tremenda di potere fine a se stessa, destinata a reiterarsi. Nella stessa scia di Walzer, e più di recente di Singer, si era collocato invece in passato Niklas Luhmann. In una conferenza tenuta a Heidelberg nel 1992, il noto sociologo aveva proposto l’ormai consueto scenario tipico dell’argomento della bomba a orologeria, ritraendo una grande quantità di terroristi (di destra e di sinistra) in possesso di diverse bombe atomiche, pronti a usarle6. Su questo sfondo egli arrivava a formulare la domanda cruciale e, dal suo punto di vista, solo retorica, relativa a cosa faremmo se ci trovassimo in quella situazione. La conclusione è che accederemmo al terreno della tortura, dimostrando coi fatti che nessuna norma possa più dirsi valida in senso assoluto, neppure quella che vieti il ricorso alla tortura. Evidente qui la doppia fallacia dell’argomentazione: da un lato, la fallacia dell’analogia tra l’individuo privato e lo Stato (di diritto), e dall’altro, la fallacia dello scenario apocalittico, immaginato nella fantasia per trarre conclusioni valide nella realtà. Come è noto, sono numerosi gli argomenti che nel dibattito internazionale, in corso da più di vent’anni, vengono avanzati per sostenere la compatibilità della tortura con un diritto democratico. Altrettanti e più forti sono però i controargomenti che si possono presentare per confutarne la correttezza e l’ammissibilità, logica e politico-morale7. Tra questi vorrei qui soffermarmi soltanto su due falsi argomenti, forse tra quelli che più di frequente ricorrono, mostrando la loro grande capacità persuasiva; inossidabili nonostante l’intrinseca precarietà teorica. Sono gli stessi falsi argomenti che vengono utilizzati spesso per giustificare le guerre, le presunte guerre “giuste”. Il primo è stato definito «argomento dei danni collaterali». Così lo descrive Ernesto Garzon Valdés nel suo bel saggio Guerra e diritti umani. «L’espressione “danni collaterali” – afferma – è un eufemismo per designare la morte di civili innocenti e la distruzione di obiettivi non militari come scuole, ospedali, musei o fabbriche destinate a una produzione non militare. Il ricorso all’argomento dei “danni collaterali” è una variante dell’argomento del doppio effetto che consente di giustificare un qualsiasi danno, purché l’intenzione del soggetto agente non sia di provocare un danno, bensì quella di perseguire un bene. La debolezza morale di questa argomentazione è nota»8. In questo contesto Garzon Valdés introduce l’argomento per contestarne la validità se usato in particolare per legittimare guerre d’intervento umanitario; la stessa obiezione che avanza per questo caso vale tuttavia senz’altro quando essa viene impiegata a favore della tortura in un contesto democratico. Si tratta di un vecchio argomento, risalente persino all’etica tomista, ma, appunto, in un ambito discorsivo e teorico ben diverso, fondato su presupposti teologici e metafisici. Se trasferito su di un terreno che non può essere né l’una cosa né l’altra, pena l’inattuale uscita da uno scenario politico e giuridico laico e democratico, non può che cedere a fronte dell’obiezione secondo la quale «contro l’’argomento dell’irrilevanza dei danni collaterali‘ si può muovere l’argomento della fallacia morale del “doppio effetto”»9, della sua non pertinenza, giusta la sua implicita, ma costitutiva, relativizzazione
L’«UNICA SOLUZIONE POSSIBILE»… È UN’ALTRA. ANCORA CONTRO LA TORTURA Leggi tutto »