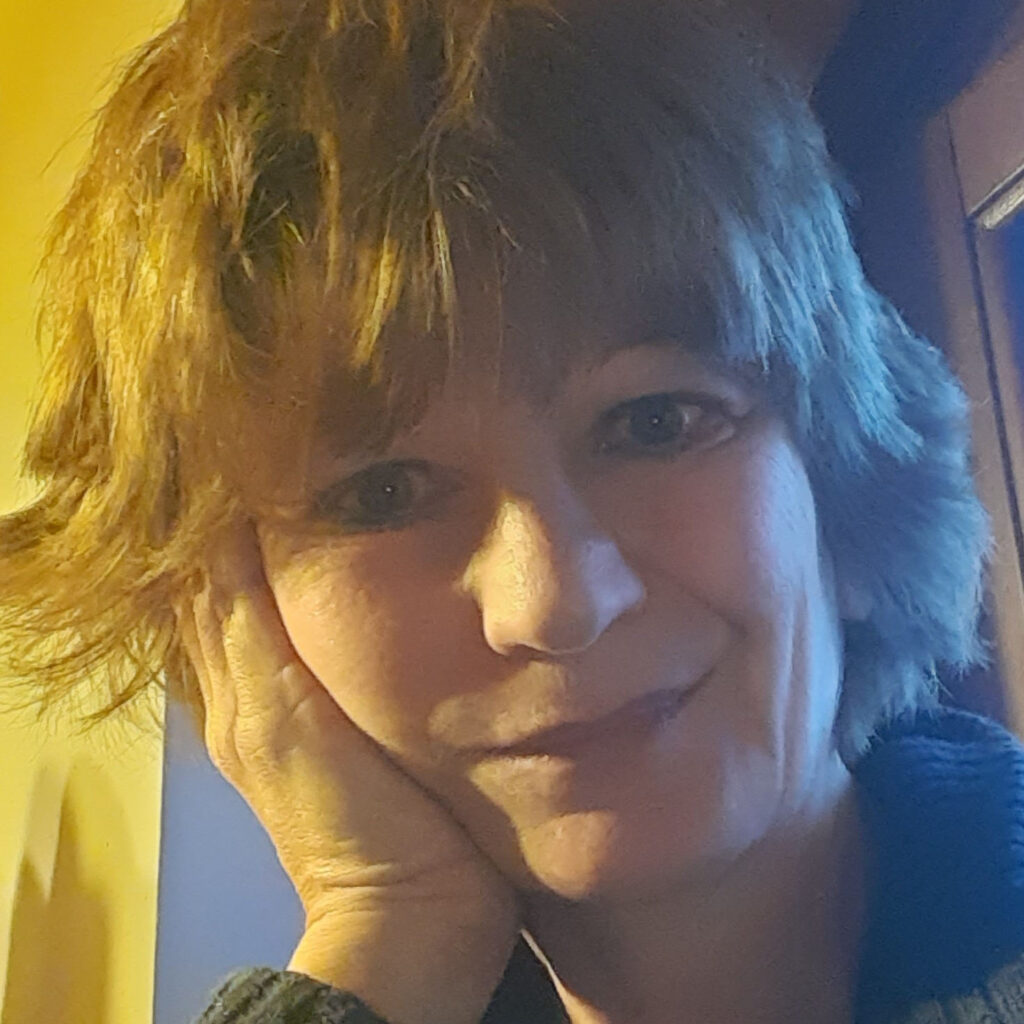ETTORE RANDAZZO, AVVOCATO E SCRITTORE
di Lucia Randazzo* – Martedì 24 giugno 2025, presso la suggestiva cornice del The Siracusa International Institute of Criminal Justice and Human Rights a Siracusa, si è tenuto un sentito evento in memoria di mio padre Ettore, difensore appassionato e scrittore raffinato, protagonista della cultura giuridica siciliana e nazionale. L’incontro è stato organizzato dal Rotary Club Monti Climiti di Siracusa, insieme all’associazione La.P.E.C.[1] e Giusto Processo “Ettore Randazzo”, con l’intento di ricordare non solo l’avvocato ma anche la sua produzione letteraria. A dare avvio all’incontro sono stati i saluti istituzionali del Segretario del The Siracusa Institute, Dott. Filippo Musca, che ha brevemente tratteggiato le principali cariche ricoperte da mio padre nel corso della sua carriera, sottolineandone il ruolo di guida morale e culturale all’interno della comunità forense e soprattutto all’interno del The Siracusa Institute (già Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali) di cui è stato anche Presidente del Consiglio Regionale Scientifico. A seguire, è intervenuto il Presidente del Rotary, Dott. Aurelio Alicata, che ha ribadito l’impegno del Club nel valorizzare figure che hanno saputo coniugare l’eccellenza professionale con l’impegno sociale e umano sottolineando la sua personale ammirazione per le sue idee su carcerazione preventiva, ragionevole durata del processo e soprattutto sulla separazione delle carriere. L’incontro, articolato e ricco di contributi, è stato condotto con competenza e sensibilità dalla giornalista Dott.ssa Laura Valvo che, dopo aver tratteggiato la carriera di mio padre con sensibilità e intensità, ha saputo guidare gli interventi con equilibrio e partecipazione, creando un clima di profondo ascolto e condivisione. Ad aprire la serie degli interventi è stata mia madre, Elisabetta Guidi, anch’ella avvocato e compagna di una vita, che ha condiviso un ricordo intenso e affettuoso, rievocando la gioia che mio padre provava nello scrivere. Elisabetta ha spiegato che il suo intento era quello di celebrare mio padre anche come scrittore. La volontà di Ettore era quella di avvicinare anche gli appartenenti al mondo non giuridico alla giustizia. Per ricordare a tutti che la Giustizia è la nostra base, ha rammentato che siamo un paese meraviglioso con una cultura giuridica antica di cui dobbiamo essere fieri. Se siamo in un paese democratico, è grazie alla Giustizia e al Giusto Processo, tanto amato da Ettore. “Un Giusto Processo che deve essere applicato secondo le regole, con un Giudice terzo e al di sopra delle parti, con un Pubblico Ministero che ricerca la verità e con un Difensore. Questo diritto meraviglioso di Difesa del cittadino. Un ruolo sociale che i media non riconoscono perché gli avvocati sono talvolta ritratti, in modo ingiusto, come “intrighini, pasticcioncelli”. No! L’avvocato è il tutore del diritto di difesa, colui che deve accompagnare chi incorre nelle maglie della giustizia ed è normale che sia giudicato secondo le regole”. Ettore si divertiva scrivendo. Era un po’ un modo di staccare la tensione emotiva dall’intenso mestiere del Difensore. Con tono partecipe e vivace, Elisabetta ha offerto al pubblico una descrizione pittoresca del romanzo Doppio inganno[2], a lei dedicato “Ad Elisabetta con i perché di una vita”, ambientato nella magica Ortigia, dove il confine tra realtà e finzione si fa sottile e letterario incuriosendo gli intervenuti sulla trama del romanzo. “Doppio inganno è un libro particolarmente bello, non solo perché traspare un amore per la Giustizia, ma traspare un amore per Siracusa, la bella Ortigia, qui chiamata Pantalica Marina, che è idealizzata. Si parla di un isolotto, che è separato da un ponte dal resto della città, con una bellissima porta spagnola, che purtroppo è stata abbattuta. Si entra in carrozza e, chi entra, apprezza la bellezza, i silenzi, il profumo di zagara, di gelsomino. Questi vicoletti ti riportano lontano. La storia è un giallo: si parla di una famiglia siracusana, in cui i personaggi si vogliono molto bene, con un senso forte della famiglia. C’è un peso su questa famiglia, una vicenda non risolta, che non vi dico… perché dovete leggerlo”. Ettore è riuscito a fare capire l’atmosfera che si vive a Siracusa e soprattutto l’incanto di Ortigia. Questo isolotto magico senza tempo. Mio zio Marcello Randazzo, anche lui avvocato, ha introdotto il libro Il pieghevole dei sogni[3]: “Una storia di famiglia che è soprattutto una storia di scelte, di sogni sacrificati, di tensioni tra il dovere verso gli altri e la fedeltà a sé stessi. Attraverso le vicende di tre generazioni — il primo Enea, il figlio Ernesto, e il secondo Enea — Ettore ci racconta un conflitto universale: quello tra gli obblighi familiari e le aspirazioni più intime… E in tutto questo, ci sono altri due protagonisti che accompagnano la vita della famiglia Latomia: lo stabilimento tipografico e l’incantevole Ortigia. Lo stabilimento, posto al pian terreno del palazzo di famiglia, con le sue macchine che lavorano instancabilmente — Tu-tu tu-tum, tu-tu Tu-tum… — quasi un respiro meccanico, costante e ipnotico. Un “mostro ammaliatore”, così lo percepiscono i suoi eredi: fonte di orgoglio e di sostentamento, ma anche di vincoli, di obblighi, di rinunce. È quel battito delle macchine che scandisce i giorni e le notti di tre generazioni di Latomia, accompagnando la vita familiare come un sottofondo inevitabile, familiare, e talvolta ingombrante. E poi Ortigia: un’isola abitata sin dalla preistoria, ideale e idealizzata nelle sue strade millenarie, nei suoi profumi, nella luce limpida che si riflette sul mare, nei canti degli uccellini del mattino. Ortigia diventa nel romanzo un personaggio essa stessa, un teatro della memoria e della vita, un luogo dove passato e presente si intrecciano in modo indissolubile. In ogni vicolo, in ogni scorcio di mare, in ogni angolo di questa terra antica, il lettore può avvertire quella sottile malinconia che solo i luoghi intrisi di storia sanno trasmettere. I temi trattati da Ettore sono temi universali che spesso tutti noi, in prima persona, o nel momento in cui sono i nostri figli a dover scegliere il proprio percorso di vita, ci troviamo ad affrontare” (…)“Ecco: nelle pieghe di questo romanzo non c’è solo la storia di una famiglia, non c’è solo una riflessione sulla giustizia. C’è, soprattutto, l’Uomo che
ETTORE RANDAZZO, AVVOCATO E SCRITTORE Leggi tutto »